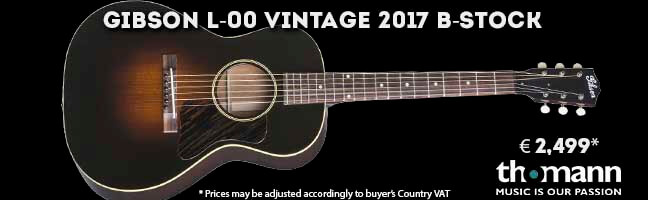Il dolce veleno del diavolo
di Vicente Mateu
Baby, I don't care where you bury my
body when I'm dead and gone
You may bury my body, hoo
Down by the highway side
So my old evil spirit
Can get a Greyhound bus and ride
Sinceramente, non importa a chi ha venduto l’anima quel
giovane ben vestito che imbraccia una chitarra, con le dita più larghe che si
siano mai viste. È l’immagine più famosa di Robert Johnson (Hazlehurst, Mississippi, 8 maggio 1911 – Greenwood,
Mississippi, 16 agosto 1938), che fu capace di scrivere l’alfabeto del blues, o almeno uno dei suoi dialetti
più importanti, con un solo pugno di canzoni registrate tra una stanza di un
hotel e un retrobottega.
Non importa perché la sua musica è il vero diavolo, quel
vecchio spirito che approfittò della sua morte prematura per saltare
sull’autobus della Greyhound che passava vicino alla sua tomba, come dice il
testo di Me And The Devil, e spargere
il suo dolce veleno per il mondo. Pochi come Robert Johnson sono riusciti ad essere così influenti con così
poco, 29 canzoni che hanno segnato la maniera di suonare e cantare da diverse
generazioni fino ad oggi. Autentici classici che si continuano a sentire oggi
giorno, in qualcuna delle mille versioni cucinate in tutte le salse possibili,
da Rambling On My Mind a Love In Vain.
Il gran mistero di Johnson
è il modo con cui afferra l’aria pesante del Delta del Mississippi per rinchiuderla nella sua chitarra. La sua
tecnica stupisce ancora oggi, ma ancor di più quell’atmosfera di autenticità
che trasmettono i suoi blues. È impossibile non sentire l’odore di alcol da
quattro spicci e sentirsi avvolti dal fumo del tabacco che ti soffia in faccia
quella donna seduta di fianco a te, al bancone di un bar polveroso in mezzo al
nulla. Forse trovi anche il tempo di ballare con lei al ritmo di They’re Red Hot senza renderti conto che
un marito geloso ti sta avvelenando il whisky.
Proprio come successe a lui l’estate del 1938, quando
era appena riuscito a farsi firmare un contratto per suonare alla Carnagie Hall
qualche mese dopo. Aveva solo 27 anni. Poi c’è anche chi dice che morì per
colpa di una meno affascinante polmonite.
Nacque, pare, nel 1911 a Hazlehurst, Mississippi, con il nome di Robert Leroy Spencer…avrebbe poi cambiato il suo cognome in Johnson quando la madre gli raccontò
chi era suo padre. Intanto la sua infanzia e adolescenza trascorrevano in un
lungo viaggio, senza mai perdere di vista il fiume e le piantagioni di cotone.
Era un giovane nero nell’America rurale del profondo sud, quella che si respira
in Milcow’s Calf.
Son House e Willie Brown rimasero stupefatti quando
lo videro suonare e specialmente Lonnie
Johnson: erano i re del blues in quel sud degli anni ’30 e diventarono i
primi maestri di un giovanissimo chitarrista. Con Robert culminò la strada che iniziarono, fra gli altri, Big Joe Williams, Tommy McClennan e Robert Petway. La sua tragedia
personale -la morte della sua seconda moglie e poi quella di suo figlio- fu ciò
che lo convertì definitivamente in musicista professionista e a vivere di
quello.
Di città in città, si ritagliò un posto nel sud degli Stati
Uniti e riuscì a contrattare un paio di sessioni di registrazione in Texas che
gli permisero di vendere un paio di migliaia di copie di Terraplane Blues, la cosa più simile a un hit per quei tempi. Il suo trucco consisteva nel dare un tocco
personale a melodie conosciute, com’è il caso di Rambling On… Finalmente sembrava che il destino gli sorridesse.
Il suo strumento era molto di più che sei corde. Riusciva a
farlo suonare come un piano, doppiarlo con la chitarra e convertirlo allo
stesso tempo in una cassa ritmica con il suo pollice. Interiora di legno invece
di microprocessori. L’armonica faceva il resto. E lo slide era la ciliegina sulla torta. Dopo la sua morte, i suoi amici
s’incaricarono di alimentare la leggenda con la sua capacità di riprodurre alla
perfezione qualsiasi cosa ascoltasse per la prima volta. Opera del diavolo,
sicuramente.
Il suo stile sincopato, eredità di Son House, avrebbe costituito le fondamenta sulle quali si erse il
rock, oltre al fatto di essere una scuola per alunni che continuano a rendergli
omaggio appena ne hanno l’occasione, da Joe
Bonamassa a Billy Gibbons senza
dimenticarci di John Mayall, uno dei
principali contribuenti della leggenda di Robert
Johnson, quando si scoprì che la magia funzionava ancora meglio con una
chitarra elettrica.
La lista dei suoi debitori è così estesa come lo è
l’enciclopedia della musica popolare degli ultimi 75 anni. È il grande mito del
blues costruito grazie a altri geni come Eric
Clapton o Keith Richards che
memorizzavano i suoi assoli con il sogno di poter un giorno suonare come lui.
Ce ne sono molti altri ancora, ma forse loro sono quelli che rappresentano
meglio la tremenda influenza di Johnson,
con il placet dei Fleetwood Mac, Led Zeppelin, The Doors, Bob
Dylan, Cream…Red Hot Chili Peppers, The White Stripes…
Ci sono specialisti che dicono che si è esagerato con
l’immagine di Johnson come icona del
blues, che la mitologia, l’archetipo del patto con il diavolo –secondo alcune
fonti, rubato a un altro bluesman- e la sua popolarizzazione a livello globale
grazie alle superstars attuali, non
corrisponde alla realtà: era un genio, ma ricordano che ce ne sono stati molti
-prima e dopo- in un genere che non finiva dove finisce il delta del
Mississippi e che il merito non è solo suo.
Affermano che è il frutto di una casualità, della riedizione
del 1961 (e poi del 1970) delle sue registrazioni di 30 anni prima in una
raccolta della Columbia con i ‘re’ del blues
del Delta, proprio nel momento in cui iniziavano ad andare in giro a
suonare molti fra quelli citati prima. Questo, e la sua leggenda maledetta,
avrebbero poi fatto il resto. Fino ad allora nessuno si era ricordato di lui.
Robert Johnson si
trovava nel momento giusto, nella casa discografica giusta, ma i suoi critici
dimenticano che questo è, precisamente, il privilegio dei geni -come lo fu lui-
destinati a cambiare il mondo, armati solo di una chitarra.