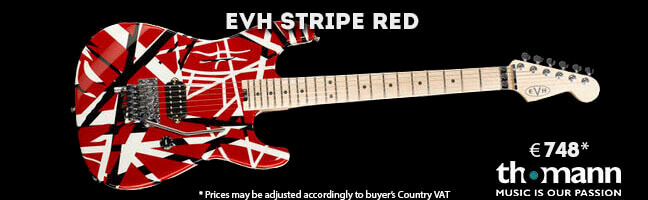Eddie Van Halen e gli impressionisti
di Alberto D. Prieto
Esattamente come successe con gli impressionisti, un giorno comparvero gli ‘heavy’, prendendo l’accessorio come base e inventando un
nuovo linguaggio. Sapevano che si stavano avventurando in territori sconosciuti
e che sarebbero stati etichettati come gente strana, storta, rumorosa. La
macchia come l’inizio del tutto, il ritmo indiavolato, l’atmosfera generale più
che la linea formale, la distorsione dello strumento… Come dipingere
un’eruzione? Come suona il fuoco? Chi ha detto che gli importasse che
arrivassero a capirli? Era sufficiente che li seguissero.
A Eddie Van Halen (1955/2020)
fin da piccolo gli andarono stretti tutti i grandi della musica. La sua
generazione si svezzò con il blues
prima ancora di conoscere a fondo il Rock
‘n’ Roll o il swing e quando gli
toccò prendere il testimone, aveva già rivoltato come un calzino tutto ciò che
c’era stato prima, perché ciò che si da per scontato è da usare e gettare e lo
è ancor di più se sei pronto a elaborare tu stesso pozioni alternative nel
momento in cui anche i tuoi amici hanno bisogno e ti chiedono un nuovo veleno.
Così, il giorno in cui prese una Gibson e cominciò a indagare, capì cose che gli altri non avrebbero
neanche sospettato, sapeva che avrebbe potuto creare atmosfere a pennellate. Al
pizzicato e agli assoli il giovane olandese aggiunse il tapping (tecnica per la quale si suonano note con le dita della
mano ritmica direttamente sulla tastiera), immaginando una nuova forma di tasti
di quel pianoforte che suo padre gli insegnò a suonare quando era piccolo. In
questo modo, senza pretenderlo, riuscì a dipingere ‘il disco heavy-rock più importante della
storia’. Questo è il titolo che le critiche specializzate del 1978 diedero al
LP ‘Van Halen’: un distillato che
concentrava i cognomi dei due fratelli leader, il nome del gruppo, il titolo
del disco e il rimedio per le ansie dei 10 milioni di alienati che scesero in
strada a spendere qualche dollaro per l’opera di questi nuovi capelloni di cui
parlavano tutti.
Senza saperlo, le corde della MusicMan di Eddie, le
bacchette di Alex Van Halen,
l’interpretazione della gola di David
Lee Roth e la tavolozza dei colori che gestiva Michael Anthony al basso, occuparono la prima linea
dell’avanguardia di quell’inizio di fine secolo. I Van Halen avevano preso gli accessori e i dettagli che gli
suggerivano i grandi delle decadi passate e li avevano convertiti nella loro
ragione d’essere necessaria per la creazione di una rivoluzione, la colonna
sonora dei ragazzi che non erano più del dopoguerra e a cui Elvis sembrava un grassone e i Queen un’imitazione addolcita della
realtà.
Così, nei primi lavori del gruppo nato a Los Angeles, si può apprezzare
l’atmosfera che crea una voce potente e rotta insieme a una chitarra rotta e
potente.
Ciò che metteva la ciliegina sonora sulle composizioni
concettuali degli Who o alle
ricerche in forma di vinile dei Led
Zeppelin, la banda di Eddie Van
Halen e di suo fratello Alex lo
convertivano nel principio di tutto.
Sulla base di queste pennellate, arrivarono i milioni di
dischi venduti e di sguardi compiacenti.
Perché il rumore non era mai abbastanza? Perché di più?
Perché così? Che necessità c’era che il ritmo frenetico fosse il punto di
partenza e non il culmine di qualcosa? Chi poteva sopportare tutto questo? Dove
saremmo finiti?
Mai. Finire, mai. Fu chiaro molto presto.
Eddie Van Halen
nacque olandese (Njimegen, 1957), come Vincent
Van Gogh (Zundert, 1853) punta di diamante del movimento pittorico
d’avanguardia. Lontana da Parigi,
fuoco della rivoluzione artistica del tardo Ottocento, alla fine degli anni ’70
del secolo successivo Los Angeles, California, divenne il centro di un
nuovo movimento, casuale come l’anteriore e casuale anche per essere la
conseguenza del genio dei suoi creatori e della necessità di trovare un nuovo
cammino espressivo.
‘Van Halen’ uscì
nel 1978 e fra i suoi pezzi troviamo un inno, Ain’t Talking ‘bout Love, e un esercizio di pazzia che sarebbe
potuto anche andare storto, Eruption:
un pezzo strumentale che cercò di dipingere tragedie con suoni. E ci riuscì,
contrariamente a ciò che suggerisce la ragione.
Quel pezzo, nato come esercizio di riscaldamento delle dita,
divenne il punto di partenza, proprio come lo furono tanti studi pittorici anni
prima. Rappresentò la consacrazione di una Stratocaster,
modificata dallo stesso Eddie, la Frankenstrat, e della personalissima
tecnica dell’autore. Un amplificatore Marshall
e un mezzo tono meno alle corde fecero il resto.
Il talento creativo del produttore, Ted Templeman, s’intrufolò con successo in uno dei pezzi del disco,
fuori dall’onda Van Halen, ma fu
proprio l’irriverenza della cover dei Kinks,
You Really Got Me, quella
reinterpretazione di un classico, adulterazione delle fonti primigenie, che ha
finito per metterli sulla scena mondiale e, soprattutto, nelle classifiche di Billboard.
Gli esercizi e le prodezze aprirono le porte, un anno dopo,
alla chitarra acustica di Spanish Fly.
A cavallo di una Ovation con corde
di nylon, Eddie mostrava un
virtuosismo equivalente al già noto con l’elettrica che generava un ronzio
‘delicatessen’ che coronava il secondo album del gruppo. Un lavoro che, proprio
come accadeva con quei pittori interessati più nel processo creativo che nel
risultato stesso, ancora una volta non aveva titolo.
Lasciarono quella moda degli anni ’70 (già praticata dagli
stessi Led Zeppelin o Queen) dopo il Van Halen II.
Infatti, da allora, la band iniziò a soffrire lo scontro fra l’ego del leader
vocale e quello spirituale, cui il palco divino aveva riempito il serbatoio di
gloria e di voglia di continuare a sperimentare.
Piccole cadute nelle vendite e un disco di versioni che
servì da scusa per approfondire nuovi generi (un po’ di funk, un’incursione nella big
band, sintetizzatori pop…), non ridussero la potenza del gruppo dal vivo,
dove erano imbattibili, e aprirono le porte a Eddie per una collaborazione con Michael Jackson, etichettata come ‘alto tradimento’ dai fanatici
dell’uno e dell’altro. Tutto questo e l’industrializzazione definitiva del business musicale attraverso la
televisione degli anni ’80, finirono per rompere la simbiosi con David Lee Roth così la banda cambiò il solista
reclutando Sammy Hagar, una voce più
‘normale’ e un’immagine meno specializzata in groupies.
Che la banda sopravvivesse al trauma di cambiare voce, che
il prodotto rimontasse nonostante quella nuova voce che portò alla produzione
di dischi più standardizzati e in linea con il suono rock degli ’80, sono la
prova che l’essenza dei Van Halen è
sempre stata il puntinismo della
chitarra di Eddie. Nei primi anni ’90, per la prima volta in dieci anni e
mezzo, fu necessario ‘pompare’ le vendite con un disco dal vivo e un altro di
grandi successi: il primo segnale che la formula si stava esaurendo. Arrivarono
le jam sessions con Gary Cherone degli Extreme al microfono, le sessioni di disintossicazione, diversi
problemi medici di Eddie e il crollo
delle vendite dell’heavy. Anche
l’avanguardia, nonostante il suo nome, rimase indietro a un certo punto. Forse
è successo quando la società era finalmente arrivata al punto che si erano
prefissi quegli artisti diversi anni prima.
In verità nessuno aveva mai suonato una Fender in quel modo, nessuno mai aveva pensato di sfruttare un
manico a due mani come Eddie Van Halen,
nessuno credette di poter spremere una Peavey
come lo fece lui. Eddie trovò le
proprie muse con la Frankenstrat a
tracolla e, così come un secolo prima nella Parigi delle ballerine prostitute e degli artisti puttanieri
qualcuno fu capace di dipingere il freddo, i tramonti e l’astio, fu lui chi
tradusse la forza tellurica in musica. Questo fu poi battezzato come Eruption e la sua tecnica di pulsare le
corde con le dita della mano ritmica, come tapping.
Ma l’avrebbero anche potuta chiamare l’opera inaugurale del nuovo
impressionismo.
Legioni di fan pagano biglietti per musei e concerti.