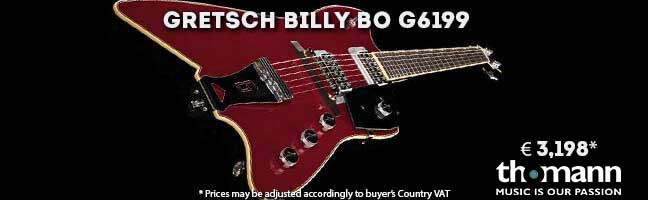Una contraddizione geniale (e brutale) in scala blues
Di Mario Benito
È il musicista più moderno che suona la musica più antica.
Il blues più primitivo che, passando dalle sue mani e dal suo plettro brutale
–il più duro che trovi- con cui colpisce le corde di una chitarra fatta di
plastica, si converte –come per magia del postmodernismo e della
decostruzione-, nel suono più nuovo di questo secolo.
Nel 2008 David
Guggenheim girò un documentario sui diversi stili e sugli strumenti di tre
grandi chitarristi rock dal titolo It
Might Get Loud (qualcosa come ‘Potrebbe
diventare rumoroso’ o, meglio, ‘A
tutto volume’). Le prime immagini ci mostrano un giovane dallo strano
aspetto, esageratamente pallido, bianco, vestito alla moda degli anni ’30 del
secolo scorso…anche se non in modo fedele, come se avesse reinventato adesso la
moda di allora, con un cappello dell’epoca come a quell’epoca non l’avrebbe
indossato nessuno, i capelli molto neri in contrasto con la faccia bianca,
lunghi davanti e sui lati e corti dietro, un taglio femminile…ma neanche. Si
mette martellare un palo di legno. Due chiodi, un fil di ferro teso fra i due,
una bottiglia vuota di Coca-Cola, un pick up rudimentale, un cavo fino a un
ampli e via, a suonare blues con lo slide.
“Chi ha detto che ci sia bisogno di una
chitarra?”, dice guardando dritto alla telecamera. È Jack White. Gli altri due chitarristi, con cui condivide
esperienze, chitarre –si, di quelle ce n’è bisogno, e non di poche, ma lo
vedremo dopo-, e perfino canzoni, sono The
Edge degli U2 e, niente meno che
Jimmy Page (se non lo conoscete
meglio non continuare a leggere questo pezzo), il signore dei Led Zeppelin.
Jack White è nato a Detroit nel 1975, la città
dell’industria americana dell’automobile ma anche della musica popolare nera
del Motown; città difficile, in continua decadenza e sommersa da una crisi
economica interminabile che ha sfociato, nel 2013, nella dichiarazione di
bancarotta. Ancor più difficile è stato nascere nel quartiere messicano di
periferia, dove viveva la sua famiglia. I suoi non gli misero quel nome così
antico e moderno al tempo stesso, che ha ora. Esattamente al contrario rispetto
al mondo anglosassone, John Anthony
Gillis –che è come si chiama in realtà- prese il cognome della moglie, Meg White, con cui formò l’insolito
gruppo di cui parliamo oggi, The White
Stripes, la band con cui raggiunse la fama e il riconoscimento
internazionale. No, non si trattava di sua sorella, come lui stesso continuava
a ripetere: era sua moglie. Qualcosa che era insolito e originale, come tutto
ciò che lo contraddistingue, perché non è molto frequente trovarsi davanti a
una band formata da una moglie alla batteria e un marito alla chitarra e alla
voce. Melodica e che grida. La cosa più sorprendente, erano i suoni brutali e
potenti che riusciva a creare quella coppia, vestita all’ultima e più antica
moda con tinte piatte, rosso, bianco, nero…colori solidi come le loro canzoni.
Blues del XXIº secolo. Possibilmente, il migliore della loro generazione.
The White Stripes nacque nel 1997 a Detroit, ovviamente.
Lavorando con suo fratello maggiore (uno dei maggiori visto che Jack è il più
piccolo di dieci fratelli, sette maschi e tre femmine), Jack ricevette la sua
prima chitarra per aver dato una mano con un trasloco. Si trattava di una Kay
Hollowbody con cassa armonica –un classico del blues- degli anni ’50. Continua
ad averla, è la chitarra, e la
possiamo vedere e, soprattutto, ascoltare in azione nel documentario insieme a
Page e The Edge. Con i White Stripes usò fondamentalmente una cosa curiosa
fabbricata in fibra di vetro e resina
(‘un pezzo di plastica vuota’, come la definisce lui stesso) di color
rosso e bianco, come il gruppo. Si tratta di una JB Hutto Montgomery Airline
del 1964.
Risulta incredibile il suono che riesce ad ottenere Jack
White con quel ‘pezzo di plastica’. Lui dice che gli piacciono le cose
difficili, che ‘sarebbe troppo facile suonare con una Gibson o una Fender
nuova’ e che ‘il male contro cui bisogna lottare in ogni campo creativo è
proprio la facilità’. Dice anche che rifugge la tecnologia –lui, il più
moderno- perché ‘ distrugge l’emozione, la verità’. Dice che lotta con le
chitarre, che vuole convertire il suo modo di suonare in una battaglia –e si
nota- con la chitarra stessa. E vuole vincere lui, ovvio.
E poi arrivò la sua altra
chitarra. Nel 2005, senza abbandonare i White Stripes, monta The Recounters insieme a Brendan Benson (voce e chitarra), Jack Lawrence (basso e cori) e Patrick Keeler (batteria), i due ultimi
già membri de The Greenhornes. Con
loro il rock fu un po’ più tradizionale
e solido, perdendo forse un po’ di freschezza e originalità. Con i Recounters
lo vediamo con una Gretsch da lui stesso modificata con l’aiuto di un liutaio
di Seattle, Randy Parsons, che
aggiunse un double cutaway, tre
pickup invece dei due originali e perfino un microfono per armonica Green
Bullet (imperdibile vedere come lo usa, gridando mentre suona). Con i
Recounters e con quella chitarra, interpreta quello che per alcuni è il suo
miglior assolo, alla fine di Blue Veins,
canzone geniale dell’album Broken Boy
Soldiers. Assolutamente brutale. Esistono persino video in cui si vede come
sanguinano le dita della sua mano destra, a forza di martellare e percuotere le
corde nel tentativo di trasmettere a chi ebbe il privilegio di assistere a quei
concerti, la sua forza e la sua passione.
Con i White Stripes suonò anche una splendida e imponente
Crestwood Astral II rossa, semiacustica. Mentre, per quanto riguarda le
acustiche, quelle che gli piacciono di più, per i loro bassi poderosi, sono le
Gretsch Rancher. Durante diversi anni, White formò parte di diversi gruppi: oltre
ai White Stripes (sciolti ufficialmente nel 2011) e ai Recounters, nel 2009
formò The Dead Weather a Nashville,
dove risiede adesso, con Alison Mosshart,
Dean Fertita (chitarra), Jack Lawrence (basso) e il proprio
White alla batteria, oltre che alla voce e alla chitarra. Con loro l’abbiamo
visto con una Gretsch Jupiter Thunderbird (la classica ‘Billy Bo’).
Pensiamo che l’album più allucinante
della sua discografia sia proprio Elephant, registrato con i White Stripe nel
2003. È il quarto lavoro del gruppo e anche se fu l’anteriore, White Blood Cells (2001), a dar loro le
prime soddisfazioni, Elephant rappresentò
la loro consacrazione e, soprattutto, l’esplosione di Jack White come
chitarrista. Tutto inizia con Seven
Nation Army, il loro più grande successo commerciale fino a oggi –una
melodia usata anche dai tifosi italiani, nel mondiale del 2006, per animare gli
azzurri-; ma include anche pezzi come
Black Math, una specie di pazzia
punk-blues con un ritornello che sembra quasi un inno e, soprattutto, Ball And Biscuits, con un altro dei suoi
assoli stratosferici in cui non solo mette a dura prova le corde della sua
chitarra di plastica ma anche i principi
dell’armonia, le scale pentatoniche del blues e qualsiasi altra considerazione
musicale…meno il ritmo. Potente come non mai. Elephant è un’opera maestra dove, in una nota sul disco, si può
leggere che “nessun computer fu usato durante la stesura, la registrazione, il
mixaggio o la masterizzazione di questo disco”.
Negli ultimi due anni, Jack White ha lanciato due dischi da
solista, Lazaretto (2014) e, prima
ancora, Blunderbuss (2012), un
autentico gioiello dove, stranamente, suona più il piano che la chitarra (…una
Telecaster!). Si. Una vera contraddizione, come tutte le cose geniali. E, vi
posso assicurare, che ciò che fa con quella
Fender è tutt’altro che semplice. White continua ad aggrapparsi alle sue radici
-non importa con quale chitarra fra le mani- mentre ricorda che a nessuno
piaceva il rock nel suo ‘difficile’ quartiere di Detroit dove si ascoltava solo
hip-hop e nessuno voleva suonare quello strumento, quando era un adolescente. A
lui non importò. Jack White voleva suonare blues, romperlo a forza di colpi, sviscerarlo,
e il risultato è blues puro perché il blues è esattamente questo.
(Immagini: ©CordonPress)