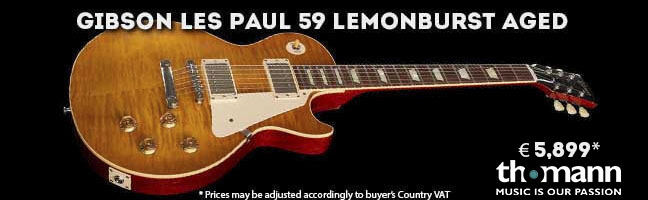Peter Green e il Santo Graal
Di Sergio Ariza
“Aveva il tono più dolce che abbia mai ascoltato, era
l’unico capace di farmi venire i sudori freddi”. Facciamo caso al re della
chitarra blues e consideriamo Peter
Green fra i più grandi chitarristi di tutti i tempi, sempre riconoscibile
in ogni sua pulsazione e capace di emozionare più lui con tre note che il più
grande dei pirotecnici delle sei corde con venti, seguendo la tradizione
dello stesso B.B. King. È anche vero, però, che se King ha suonato ai massimi livelli per settant’anni, il tempo in cui
Green suonò al massimo livello si riduce al periodo compreso fra il 1967 e il
1970, anni in cui Peter Green fu Clapton
dopo Clapton e Jimmy Page prima di
Jimmy Page o, che è lo stesso, il successore del primo ed il predecessore del
secondo.
Tutto ciò che gira intorno a Green è avvolto da miti e
leggende, i suoi problemi mentali, per colpa delle droghe, ci impedirono di goderci
fino in fondo uno dei chitarristi britannici imprescindibili, uno che, se non
fosse stato per le circostanze, potremmo mettere sullo stesso piano di Clapton e Page, due chitarristi che lo
hanno considerato sempre fra i più grandi. Fu capace, come loro, di dare una
visione personale del blues rock, avvicinandosi a volte a territori ‘hard
rock’, anche se i suoi migliori momenti sono di solito legati al tono più dolce
che si sia mai ascoltato. Un tono di cui è responsabile, in parte, la sua
chitarra, nota fra gli esperti come il Santo Graal, una Les Paul Standard del
1959 con ‘poteri magici’, che poteva suonare come una Les Paul ma anche come
una Stratocaster. La sua storia va assolutamente legata a quella della
chitarra, la mitica ‘Greeny’.
Peter Green iniziò la sua carriera come chitarrista nella
band di Peter Barden, i Peter B’s Looners, dove coincise per la
prima volta con il batterista Mick
Fleetwood, l’uomo che l’avrebbe accompagnato alla batteria in quasi
tutti i pezzi fondamentali della sua carriera. Con loro registrò il primo
pezzo, un single dove il lato A era una versione strumentale di If You Wanna Be Happy di Jimmy Soul. Ma fu solo l’anno dopo
quando la sua carriera diede un giro fondamentale, occupando il posto più
ambito da tutti i chitarristi britannici, quello di sostituto di Eric Clapton
nei Bluesbrakers di John Mayall. Fu in quell’epoca che
Peter Green mise le mani sulla sua ‘magica’ Les Paul, come fece Arturo con
Excalibur, per diventare il Re d’Inghilterra. Curiosamente fu dopo aver visto
Clapton con un’altra chitarra mitica, la sua Les Paul Sunburst, battezzata
successivamente ‘Beano’, come il titolo del comic
che l’autore di Layla teneva fra le
mani nella copertina dell’unico disco che fece con Mayall e los Bluesbrakers.
Clapton se n’era andato per formare i Cream e John Mayall poteva scegliere fra i migliori chitarristi
delle isole britanniche chi avrebbe occupato il suo posto. La sua decisione
dimostrò che sapeva scegliere bene un chitarrista. Quando un produttore della
Decca entrò nello studio di registrazione e notò che non c’era l’amplificatore
di Slowhand, chiese a Mayall dov’era la sua
star e la risposta che ricevette lo lasciò senza parole: “Non è più con noi, ci ha
lasciato qualche settimana fa. Ma non preoccuparti, ne abbiamo uno migliore”.
Green non volle far sfigurare il suo capo e compose il miglior pezzo dell’album
intitolato Hard Road, la strumentale The Supernatural, che ben si può
considerare come le fondamenta dei Fleetwood
Mac, oltre a precedere uno dei suoi pezzi più mitici, Albatross. Il tono particolare che Green tirò fuori dalla sua Les
Paul fu considerato molti anni dopo come uno dei 50 migliori di tutti i tempi,
secondo la rivista Guitar Player. In verità il suono di Greeny è quasi
leggendario: si dice che per un errore di fabbrica, uno dei pick up fu montato
al contrario, facendo in modo che quando suonasse con tutti e due i pickup
venisse fuori un suono tipo 'out-of-phase', e simile a una Stratocaster.
Alla fine, la sua storia nei Bluesbrakers fu fugace quanto
quella di Clapton. Ed egualmente fruttifera, visto che lasciò un’impressione
all’altezza del suo predecessore. Quando nel 1967 decise di formare la sua
propria band di blues rock, Green era già una stella ed aveva un soprannome
tutto suo: se Clapton era ‘Dio’, lui era il ‘Dio Verde’ (Green God). Ma fu in quel momento che rivelò il suo essere
‘ribelle’, stanco degli eccessivi complimenti e dell’alta stima che si
sbandierava per i chitarristi, decise di chiamare il suo progetto con i cognomi
del suo batterista e bassista preferiti, con cui aveva militato nei Bluesbrakers,
Mick Fleetwood e John McVie. Il primo non ci pensò due
volte, avendo avuto già diversi problemi con Mayall per il suo problema con
l’alcool, il secondo s’incorporò qualche mese dopo, quando il progetto risultò
avere qualche possibilità di sopravvivere, soprattutto economicamente. Per
completare la prima formazione del gruppo, Green reclutò un giovane pupillo
chiamato Jeremy Spencer, che suonava
la chitarra slide, per non avere tutti gli occhi puntati solo su di sé. E fu
così al punto che il primo single, intitolato I Believe My Time Ain’t Long, una versione di Dust My Broom di Elmore
James, la cantava lo stesso Spencer.
Fleetwood Mac, il
primo disco della band, comparve sulla scena poco dopo, nel febbraio del 1968.
Una collezione di classici del blues, come Hellhound
On My trail di Robert Johnson o Shake Your Money Maker di Elmore James, oltre a varie canzoni
originali, cinque di Green e tre di Spencer. Mentre quelle di Green sono
spettacolari, come Long Grey Mare o Merry Go Round, quelle del giovane
Spencer non sono all’altezza. Il suo sforzo per allontanarsi dalle luci dei
riflettori e condividere il peso del gruppo, fece in modo che nessuno dei loro
dischi raggiunse il livello che aveva Green. Comunque, nonostante tutto, si
convertirono nella ‘next big thing’ e tutto l’ambiente musicale dell’epoca
considerava i Fleetwood Mac ed il suo leader Peter Green come quelli che
avevano più futuro e possibilità di sfondare nell’industria britannica. I passi
seguenti gli diedero ragione: il gruppo pubblicò le incredibili Black Magic Woman di Green –che Santana avrebbe poi convertito in un
successo a scala mondiale pochi anni dopo- e Need Your Love So Bad, la canzone che probabilmente aveva in mente
B.B. King quando disse la frase con cui inizia quest’articolo. In quei pezzi si
poteva avere la prova che Green non solo suonasse come gli angeli, ma anche che
la sua voce fosse all’altezza dei grandi artisti di blues che tanto avevano
influito nei suoi inizi.
Le richieste erano così tante che sei mesi dopo il loro
debutto usciva nei negozi il secondo disco della band, Mr. Wonderful. Un disco in cui si notava il poco tempo che avevano
avuto per farlo, con quattro canzoni che cominciavano con lo stesso riff
‘copiato’ da Elmore James, cortesia di Jeremy Spencer. Come curiosità, possiamo
aggiungere che fu anche il primo disco in cui suonò la tastierista Christine Perfect, futura sposa di John
McVie e membro fondamentale del gruppo durante l’epoca di più successo. Ma
torniamo al buon Peter Green, che nell’ottobre del 1968 decise di incorporare
un terzo chitarrista, il giovane diciottenne Danny Kirwan, una volta compreso che Jeremy Spencer non sarebbe mai
uscito dall’orbita di Elmore James e i suoi contributi alle canzoni iniziavano
a essere ben pochi. L’operazione riuscì alla perfezione: il primo singolo che
registrarono con la nuova formazione, la strumentale Albatross, divenne il loro primo ‘numero 1’ nelle liste inglesi.
Registrata il 22 Novembre del ’68, la canzone era stata composta da Green,
basandosi su un famoso pezzo degli anni ’50, Sleep Walk, di Santo &
Johnny. Spencer non partecipò alla registrazione e Green non usò la sua
Greeny ma una Fender Stratocaster e un amplificatore Orange Matamp OR100. La
canzone divenne un grande successo nel suo paese natale e influì su molti
chitarristi come David Gilmour dei Pink Floyd e perfino sui Beatles (ne è una prova Sun King del disco Abbey Road, basata su quel pezzo).
La continuazione, nell’aprile del 1969, sarebbe stata la
conferma assoluta del gruppo: Man Of The
World, un altro classico uscito dalla penna di Green e in cui usa il testo
per esprimere il suo disgusto verso la fama anche se, paradossalmente, la
canzone salì fino ai posti più alti, raggiungendo il numero due delle
classifiche inglesi. Qui torna l’inconfondibile tono di Greeny in uno dei suoi
assoli più memorabili. Dopo poco la band iniziò a registrare il loro terzo
disco, Then Play On, pubblicato in
Settembre, il primo con Kirwan come
membro e che fu il risultato di quel che probabilmente sia il loro miglior
lavoro. Durante quelle stesse sessioni, registrarono un altro dei suoi classici
inconfondibili, Oh Well, una canzone
di più di 9 minuti, divisa in due parti totalmente differenti, composte da
Green; la prima costruita su un potente riff, vicino all’hard rock, e una
seconda strumentale in cui Green suona una chitarra spagnola Ramírez, con
influenze classiche. La seconda parte era proprio quella che Green preferiva,
quella che aveva composto per prima, ma fu la forma della prima, con il suo
potente riff strumentale, poi l’entrata del gruppo e uno stop per fare entrare
la voce che ispirò uno dei suoi più grandi seguaci a scrivereuna delle canzoni
più famose della storia. Si trattava di Jimmy
Page e di Black Dog. Page ha
sempre riconosciuto Green come una grande influenza e quando si unì ai Black Crows per registrare il disco Live At The Greek, insieme ai successi
dei Led Zeppelin aggiunse Oh Well dei
Fleetwood Mac.
Then Play On
conteneva anche un altro classico di Green, Rattlesnake
Shake, una delle canzoni favorite del batterista Mick Fleetwood, che la
considerava come il suo modo di fare una ‘jam’ come i Grateful Dead.
Con Oh Well al
secondo posto delle classifiche e Then
Play On fra i dieci dischi più venduti, sembrava filare tutto liscio per la
band che aveva iniziato a comparire anche nelle classifiche americane, in un
paese dove erano andati in tour con discreto successo insieme ai Ten Years After. Ma tutto era sul punto
di saltare in aria. La salute di Peter Green iniziava a vacillare e l’eccessivo
uso di LSD non faceva altro che peggiorare la situazione. Il momento chiave,
come ricorda il bassista John McVie, si produsse a Monaco nel marzo del ’70
quando Green finì in una comunità hippie iniziando un viaggio con gli acidi dal
quale non sarebbe mai tornato del tutto. Aveva deciso di restarci in quella
comunità fino a che gli altri membri della band non lo scoprirono e lo tirarono
fuori. Ma qualcosa era cambiato, Green aveva radicalizzato il suo rifiuto del
successo e delle ricchezze e cercò di convincere il resto del gruppo a donare
tutti i loro soldi e possedimenti e quando questi si negarono, lasciò la band.
Non senza dare un’ultima prova di lucidità e talento nell’ultima canzone
che registrò col gruppo prima di abbandonarli definitivamente, The Green Manalishi. Una canzone in cui
comparava il denaro al diavolo e che sembra documentare fedelmente la sua lotta
per fermare la sua lenta caduta nella pazzia. Disgraziatamente per tutti, perse
quella battaglia. Il suo ultimo concerto con i Fleetwood Mac fu il 20 maggio
del 1970, cinque giorni dopo l’uscita di The
Green Manalishi sul mercato.
La sua carriera e il suo modo unico di suonare, non
sarebbero mai tornati come prima. Nel giugno del ’70 accompagnò il suo vecchio
capo, John Mayall, in un concerto e nello stesso periodo registrò una jam
session che sarebbe stata poi lanciata a dicembre con il significativo titolo
di The End Of The Game, un disco
lontano dal suono che lo aveva caratterizzato nei Fleetwood Mac, con
distorsioni alla Hendrix ma senza il
suo tono particolare e, senza dubbio, senza la sua magia. Era la prova di un
qualcosa che gli si era rotto, perso dentro e che non avrebbe mai più
ritrovato. Con la magia se ne andò anche la sua chitarra: poco prima di
abbandonare i Fleetwood Mac, il gruppo che lui stesso aveva creato, Green aveva
iniziato a regalare tutto ciò che possedeva e la più pregiata andò a finire
nelle mani di un giovane chitarrista irlandese di appena 18 anni. Si trattava
di Gary Moore. Dopo poco, ciò che
era iniziato come un prestito, finì per diventare un ‘quasi-regalo’. Moore
aveva detto a Green che non avrebbe potuto far fronte al prezzo della chitarra
e questi gli rispose che avrebbe accettato in cambio la somma di denaro che
Moore avrebbe messo su con la vendita della sua SG. Moore accettò l’accordo e
finalmente pagò a Green più o meno 300 dollari per Greeny. Quando nel 2006,
afflitto da problemi economici, decise di venderla, lo fece per 2 milioni di
dollari. Otto anni dopo sarebbe poi arrivata nelle mani di un altro asso della
chitarra, quando Kirk Hammett dei Metallica,
su consiglio di Jimmy Page, s’impossessò del Santo Graal delle chitarre e
Greeny tornò a suonare in un disco, in concreto, nell’ultimo della band
americana, Harwired...To Self Destruct.
Green, da parte sua, sarebbe tornato dall’inferno della
demenza e della schizofrenia (rimase internato in diversi ospedali psichiatrici
e ricevette trattamenti di elettroshock durante gli anni ’70), ma non avrebbe
mai più suonato come prima. Tornò persino a suonare in un disco dei Fleetwood
Mac, in concreto in Tusk, con la
formazione definitiva con Lindsey Buckingham, Stevie Nicks e Christine McVie,
anche se il suo contributo non fu registrato.
Alla fine degli anni ’90 iniziò un tour con il suo gruppo Peter Green Splinter e ricevette
l’affetto del pubblico. Ci fu persino un tentativo da parte della Gibson di
fare una Les Paul Peter Green ma, dopo aver lasciato partire la sua Greeny, era
passato a una Gibson Howard Roberts Fusion e non se ne fece più nulla. Lo
stampo si era rotto tempo prima e nessuno, neppure lui, era stato capace di
‘replicare’ il ‘tono più dolce’ che si sia mai ascoltato da una chitarra
elettrica.