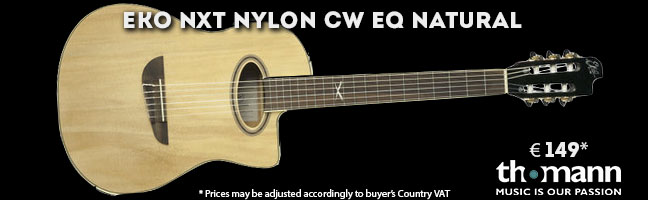Django Reinhardt
Una chitarra nata in mezzo alla strada
Di Vicente Mateu
“Quella chitarra che ride e
piange, chitarra con voce umana”
(Jean
Cocteau)
I gitani
sanno cosa vuol dire soffrire. E sanno anche come trasformare il dolore in
musica piena di vitalità e allegria sotto cui resta sepolta quella tristezza
ancestrale. Erano i suoni, oggi quasi scomparsi, che si sentivano nelle
periferie delle grandi città europee della prima metà del secolo scorso, un
paesaggio di carrozzoni e miseria. Jean
Baptiste ‘Django’ Reinhardt (Belgio
1910 – Francia 1953) scelse una chitarra come forma di espressione in un mondo
in guerra che nel suo caso aprì un altro fronte con la sua tragedia personale.
La sua ‘medicina’ fu invadere il regno dello swing con l’aroma delle sue
canzoni, che aveva ascoltato fin da piccolo nel campo del suo clan, appena
fuori Parigi. Con un’eterna sigaretta pendendo dalle sue labbra e con il suo caratteristico
baffetto, il jazz cadde ai suoi piedi creando un genere solo per lui e per la
sua etnia, scrivendo un capitolo di storia di un’altra leggenda delle sei
corde. Il gypsy jazz o, in francese, manouche
jazz, era nato in mezzo alla strada.
Una casa
itinerante che arrivò alla fine del cammino troppo presto. È la maledizione dei
geni, o almeno di molti di loro, un destino che sembra prendersela specialmente
con pionieri come Reinhardt. Se lo
portò via un ictus a Fointnebleau, proprio quando l’Europa si stava riprendendo
dai massacri sui campi di battaglia e stava scoprendo la chitarra elettrica.
Sfortunatamente fece appena in tempo a sperimentare con uno strumento cui
l’elettronica aveva moltiplicato –e amplificato- esponenzialmente le possibilità.
La
chitarra elettrica arrivò tardi per Django.
Sui palcoscenici che frequentava, il posto dei Marshall lo occupavano un
contrabbasso e un paio di chitarre ritmiche –una era quella di suo fratello Joseph- mentre la sua dialogava con il
violino di Stéphane Grappelli. Il suo
‘interlocutore’, che sapeva leggere uno spartito, è un personaggio fondamentale
per capire perché Reinhardt influì
tanto nel jazz. La sua eredità arrivò fino a molti altri chitarristi che hanno
cercato di seguire il suo esempio, da Carlos
Santana fino a Jimi Hendrix e la
sua Band of Gypsys, il suo
particolare omaggio al gran maestro.
Con un
gruppo poco usuale per quei tempi, senza piano ne fiati, solo corde, Reinhardt liberò il genere musicale dai
legami delle tradizioni, ma senza l’aiuto di un musicista ‘serio’ come Grappelli, un gitano che non solo non
sapeva leggere uno spartito, ma che a mala pena sapeva leggere e scrivere,
forse non sarebbe mai riuscito ad attirare l’attenzione e suscitare
l’ammirazione dei suoi colleghi. “Jiango Renard” fu il nome che scarabocchiò
sulla sua prima registrazione con il fisarmonicista Jean Vaissade, impressionato da quel ragazzo con dita prodigiose e
un orecchio che suppliva di gran lunga le sue carenze ‘accademiche’. Come tanti
altri, cominciò con un banjo. O uno strumento che gli assomigliava.
Quella
fu la parte facile. Appena diciottenne, Reinhardt
dovette superare una sfida ancor più grande per colpa di uno stupido incidente,
quello del famoso incendio della roulotte, dove viveva con la sua prima moglie,
venditrice ambulante di fiori di celluloide cui una candela convertì in un
inferno e in quasi inutilizzabili il mignolo e l’anulare della sua mano
sinistra. Il peggior incubo per un chitarrista. Sicuramente gli provocò un
dolore maggiore rispetto alla gamba che rischiò di vedersi amputata.
Due anni
dopo, il chitarrista gitano non solo non si era arreso ma aveva imparato a
usare l’indice e il medio come se fossero quattro. Gli altri due a mala pena
gli servivano per qualche accordo. Un’altra persona sarebbe impazzita; Django divenne un genio. Quella
disgrazia gli insegnò a tirar fuori nuovi suoni dalla chitarra che gli regalò
il fratello, definita da uno stile molto personale a causa di una mano avariata
che lo rendeva ‘distinto’; il suo ‘tocco’, quello delle radici che si perdevano
nella notte dei tempi, si occupò del resto.
Fu in
quell’epoca che si buttò a capofitto nel jazz, grazie al Dallas Blues di Louis
Armstrong. Erano gli anni ’30 e Django
suonava di locale in locale fino a che il proprietario di un club di
Parigi, Pierre Nourry, lo prese,
insieme a Grappelli, nel Quintet of the Hot Club of France, una
marca che esiste ancora oggi. Fu il salto che lo portò al successo, alimentato
a livello mondiale da quei ‘mattoni’ di vinile con lo storico logo Decca
piazzato proprio al centro. Nel suo curriculum ci sono più di 250 registrazioni
e migliaia di brani. Da quel periodo procedono alcune delle sue poche composizioni
proprie come Djangology, Bricktop o Swing 39. Tutte composte grazie all’aiuto di Grappelli.
La
musica di quei dischi durò solo pochi anni prima di essere sostituita dalle
cannonate dell’artiglieria tedesca. Ma la guerra non frenò Reinhardt, che preferì tornare in Francia invece di restare a
Londra con i suoi compagni, Grappelli incluso.
Mentre aspettava che passasse la tormenta, montò una big band insieme al
clarinettista Hubert Rostaing
nonostante il rischio che correva in piena occupazione nazista. I gitani erano
carne da campo di concentramento, un rischio che scampò, protetto dalla
passione per il jazz di uno dei suoi possibili carcerieri. Come finì per essere
un mito della resistenza, quella è un’altra storia. La verità è che la sua
musica era indispensabile per animare le notti della capitale francese.
Django riuscì a sopravvivere per
ricevere la valanga di musicisti statunitensi che sbarcarono dopo la
liberazione della città parigina. Tornavano i bei tempi, la gente riempiva i
club, impazienti di dimenticarsi della guerra. Nel 1946 finalmente ebbe fra le
mani una chitarra elettrica con cui iniziare a esercitarsi. L’aspettava un tour
negli Stati Uniti come solista niente meno che con Duke Ellington, uno dei responsabili della sua ‘fusion’ con il
jazz. Nonostante qualcosa andò storto –ci sono diverse versioni al riguardo- e
tornò nel Vecchio Continente alla sua vita di sempre, incluso l’ineffabile Grappelli. Ancora una volta il
violinista veniva in aiuto del chitarrista cui l’elettricità e il nuovo stile
di moda, il bebop, non gli avevano fatto proprio un bell’effetto.
Lo swing
era fatto per lui. Di ritorno a casa –è un modo di dire perché non rinunciò mai
a vivere come un nomade- era una stella per il grande pubblico e condivideva il
palcoscenico di Parigi (1948) con il non meno grande Dizzy Gillepsie. Django,
tuttavia, esasperò il suo lato tribale negli ultimi anni. Le sue apparizioni si
fecero sempre più rare e ancor di più le uscite dal suo ritiro parigino, come
il tour in Italia, una delle sue ultime registrazioni. Raggiunti i 40 anni,
sembrava si sentisse fuori luogo: si dedicava a pescare e a poco più,
circondato sempre e solo dalla sua ‘gente’. Come se fosse cosciente che si
avvicinava la sua fine.
Fra gli
esperti c’è una certa unanimità: con la chitarra elettrificata non raggiunse
mai lo stesso livello di virtuosismo che aveva con la sua chitarra Selmer, disegnata su misura dal gran
liutaio italiano Maccaferri. La
stessa che non ebbe a portata di mano quando conobbe Andrés Segovia, un altro dei succosi aneddoti che troviamo nella
sua biografia.
Sicuramente
non ebbe il tempo o non trovò la chitarra elettrica che faceva al caso suo. Django Reinhardt attraversò due guerre
senza mai smettere di suonare la chitarra. Per farla stare zitta, ci volle una
vena rotta nella sua testa, che scrisse troppo presto l’ultimo capitolo della
sua vita e il primo di un’altra leggenda con un posto d’onore nel jukebox di Guitars Exchange.
(Immagini: © Cordon Press)